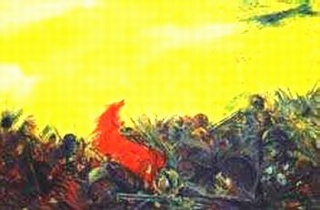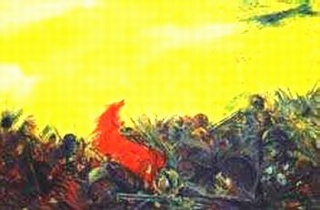In una valle remota al confine fra il Laos e il
Vietnam settentrionale, circondata dalla jungla, dalle coltivazioni di riso e di
oppio delle popolazioni indigene, in quella che venne tramandata ai posteri come
la
Battaglia di Dien Bien Phu, si consumò l'episodio più drammatico del
processo di decolonizzazione francese. Fra il 13 marzo e l'8 maggio del 1954,
sotto il fuoco incessante dell'artiglieria dell'Esercito popolare vietnamita,
debilitati dallo sforzo fisico, dall'insonnia e dalla mancanza di
approviggionamenti, persero la vita quasi diecimila fra i migliori uomini di cui
potesse disporre l'esercito francese. Con loro scomparve ogni velleità, da parte
di Parigi, di porre fine a proprio vantaggio alla questione indocinese, ponendo
le premesse per l'intervento americano e ulteriori interminabili vent'anni di
instabilità nell'intera regione. La decisione, che avrebbe portato ai tristi
avvenimenti, seppur costellati da episodi di singolare eroismo, dei 55 giorni in
cui si svolse la battaglia, era stata presa mesi addietro dal tenente generale
Henri Navarre, negli acquartieramenti del comando francese ad Hanoi. Navarre,
che il 28 maggio del 1953 aveva sostituito al comando delle operazioni militari
in Indocina il generale Salan, sarebbe stato, almeno per il decennio successivo,
oggetto delle critiche sia della stampa francese e americana sia dei suoi
sottoposti, considerato come il principale responsabile della disfatta francese.
Non minore dell'intensità delle accuse fu però l'entusiasmo con cui venne
accolto l'avvicendamento fra Navarre e Salan. Il
Time pubblicò un
articolo in cui , parlando del nuovo comandante francese, si leggeva: "Un anno
fa nessuno di noi avrebbe potuto vedere la vittoria. Ora la possiamo scorgere
chiaramente, come la luce alla fine del tunnell". Il curriculum di Navarre era
del resto degno di buona parte della fiducia che gli veniva riposta. Classe
1898, aveva ricevuto il battesimo del fuoco, da cadetto, sul fronte occidentale,
nel maggio del 1917. Con la conclusione del primo conflitto mondiale fu
assegnato a un reparto in Siria, dove per due anni partecipò ad azioni di
antiguerriglia contro i ribelli arabi. Successivamente, dopo un periodo in
Germania con le truppe di occupazione francesi e gli studi al Collegio Militare,
dal 1930 al 1934 si trovò di nuovo impegnato in azioni antiguerriglia in
Marocco. A partire dal 1937 venne destinato al
Servizio Informazioni
dell'esercito dove, fra il 1938 e il 1940, poco più che quarantenne, fu a capo
della sezione tedesca. Con l'occupazione nazista, Navarre partecipò alle azioni
di
intelligence del movimento clandestino per poi assumere il comando
del 5° reggimento corazzato
Spahi. Poco dopo raggiunse il comando della
V Divisione Corazzata in Germania e, prima della partenza per l'Indocina,
ricopriva la carica di capo dello staff al comando delle truppe di terra della
NATO in Europa centrale. L'ottimismo generale non corrispondeva però alla
situazione effettiva del fronte. Nel Viet Nam settentrionale il controllo
francese si limitava quasi esclusivamente alla zona del Delta del Fiume Rosso,
all'interno della cui area è situata anche Hanoi, sotto la minaccia costante
della guerriglia comunista.
Lai Chau, nel nordovest del paese, che il
governo filofrancese aveva eletto a propria capitale, si trovava in una
condizione ancor più critica, stretta nella morsa dei regolari dell'Esercito
Popolare Vietnamita. Il sud della nazione si trovava in una contingenza
relativamente più tranquilla. L'esercito
 |
Un lancio di
paracadutisti francesi in preparazione
di un attacco alle retrovie dei
vietminh |
rivoluzionario non era in grado di
mantenere una posizione d'attacco, come accadeva al nord, ma stava rafforzando
le proprie difese a nord di Nha Trang, dove occupava un'area in cui risiedevano
3 milioni di vietnamiti. La presenza della divisione 316 ai confini con il Laos
rendeva inoltre non del tutto improbabile l'eventualità dell'invasione. Infine,
il recente armistizio che aveva portato al termine la guerra in Corea,
consentiva alla Cina di inviare ulteriori mezzi, e anche uomini, a sostegno
dell'azione comunista. La cui propaganda, basata sull'idea della lotta
all'imperialismo occidentale, stava oltretutto registrando un discreto successo.
Le posizioni francesi soffrivano invece della scarsità di rinforzi, che
giungevano dalla madrepatria con gran parsimonia, e del personale necessario in
ruoli vitali come l'aviazione. Consapevole della necessità di una immediata
azione in grado di contrastare e eventualmente prevenire l'attacco nemico,
Navarre, dietro l'iniziale suggerimento del generale Cogny, a capo delle
operazioni nello scacchiere settentrionale, prese l'infausta decisione di
occupare Dien Bien Phu.
Il villaggio, al centro di un altopiano
relativamente ampio e percorso dal fiume Nam Yum, aveva attirato l'attrenzione
del comando francese sia per la sua prossimità con il Laos e Lai Chau, sia per
la caratteristica pianeggiante del territorio che avrebbe facilmente permesso la
realizzazione di una base aereo terrestre. Si trovava inoltre all'incrocio fra
la
Route 41 e la
Piste Pavie, due vie di comunicazione al
momento utilizzate dai comunisti per i propri rifornimenti. Circondato da alture
elevate e da una fitta vegetazione, al punto da rendere oltremodo arduo, se non
impossibile, il cammino perfino a unità di fanteria ben equipaggiate e abituate
alle sfavorevoli condizioni del clima tropicale, si dimostrerà, nei mesi
successivi, altrettanto adatta a venire stretta nella morsa della manovra
avvolgente nemica. A Dien Bien Phu si trovava anche una pista aerea utilizzata
più di una volta durante il secondo conflitto mondiale dalle unità alleate,
nonostante fosse ufficialmente sotto il controllo della Repubblica di Vichy. Le
unità dell'Esercito popolare vietnamita, che non disponevano di un'aviazione,
preso il possesso della valle, agli inizi del 1952, avevano coscienziosamente
sabotato la pista, ma la sua presenza era di estremo interesse per il comando
francese.Soprattutto in un primo momento, quando si era pensato di utilizzare
Dien Bien Phu per liberare dall'assedio la base di Na San, in seguito evacuata
con successo grazie all'intervento dell'aviazione.
Il 20 Novembre del 1953,
quando ebbe inizio l'operazione Castor, Na San era già caduta in mani nemiche,
ma il suo assedio, che senza portare ad alcun sostanziale progresso logorava
sensibilmente l'esercito insurrezionale, aveva infuso fiducia fra i vertici
francesi.
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
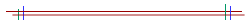 |
 |
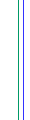 |
Alle 5 del
mattino
del 20 novembre
1953, un C-47
si dirigeva verso
Dien
Bien Phu |
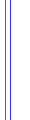 |
 |
 |
 |
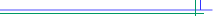 |
 |
Soprattutto
in Navarre che, pur conscio dei rischi che avrebbe potuto comportare, aveva
intravisto la possibilità di annientare parte delle divisioni nemiche
attirandole in uno scontro a Dien Bien Phu. Negli stessi giorni in cui i
francesi prendevano possesso del villaggio, il medesimo scenario era stato
analizzato dai comandi dell'Esercito Popolare Vietnamita. Il generale Va Nguen
Giap, il futuro artefice della vittoria, aveva accettato la sfida, conscio che,
se l'intera macchina bellica comunista si fosse mossa con il vigore necessario,
l'armata francese era chiusa in una trappola. Alle 5 del mattino del 20 novembre
del 1953, un C-47 da trasporto, un due motori di fabbricazione americana,
prendeva il volo dall'areoporto militare di Bach Mai, nei pressi di Hanoi. A
bordo si trovavano il tenente generale Pierre Bodet, comandante in capo
dell'aviazione francese in Indochina, il brigadiere generale Jean Dechaux,
comandante di
Gatac Nord, il gruppo tattico dell'aviazione cui facevano
riferimento le azioni aeree nel nord dell'Indochina, e il brigadiere generale
Jean Gilles, comandante delle truppe aerotrasportate.
Il velivolo si
dirigeva in direzione di Dien Bien Phu con il duplice obiettivo di osservare se
le condizioni atmosferiche sopra la valle fossero favorevoli per il lancio e,
eventualmente, di sganciare le prime unità paracadutiste, con il compito di
segnare le zone di atterraggio per le ondate successive. Alle 7:20 il maggior
generale Renè Cogny, ad Hanoi, ricevette il messaggio che dava via libera
all'operazione
Castor. Alle 10:30 il
6°
BPC (
Battaglione Paracadutista Coloniale ) del maggiore Marcel Bigeard e il
II RCP ( Secondo Battaglione del Primo Reggimento della
Fanteria Leggera Paracadutisti ), rispettivamente di 651 e 827 uomini, di cui
620 vietnamiti, facevano la propria comparsa nei cieli di Dien Bien Phu.
Inaspettatamente si trovavano ad accoglierli, all'interno del villaggio, il 148°
Reggimento Indipendente dell'Esercito Popolare Vietnamita e la 226° compagnia
dell'Artiglieria Pesante, ma l'ampio raggio in cui avvenne il lancio, permise ai
paracadutisti francesi di prendere posizione prima che il nemico potesse
concentrare il fuoco su di loro. Alle 13.30 i 911 uomini del
I BPC
ranggiunsero la zona di lancio. Lo scontro, durato poco più di sei ore, si era
concluso a netto vantaggio dei francesi, i quali avevano riportato solo 11 morti
e 52 feriti. I vietnamiti avevano però saputo ritirarsi con ordine, sfuggendo
alla possibilità di un accerchiamento e portando con sè gran parte dei feriti.
Lasciando comunque sul campo quasi cento cadaveri e la maggior parte dei
documenti del reggimento. I giorni successivi videro i paracadutisti francesi
consolidare la propria posizione senza però eccessivi sforzi nella costruzione
di un solido sistema difensivo. Sarebbe stato il compito delle unità di fanteria
che li avrebbero sostituiti. Oltretutto nei piani originali Dien Bien Phu
sarebbe dovuta essere una base da cui lanciare brevi sortite contro le posizioni
nemiche, piuttosto che una roccaforte capace di resistere ad un lungo assedio. I
primi sforzi furono concentrati in operazioni di perlustrazione e nel recupero
della pista aerea della base. Cogny, che nel frattempo aveva promesso a Gilles
di sollevarlo dall'incarico della difesa della valle, aveva scelto di affidare
il comando al colonnello de Castries. Christian Marie Ferdinand de la Croix de
Castries era nato a Parigi 52 anni prima. La sua figura elegante e aristocratica
ben si addiceva al suo lignaggio, uno dei più nobili di tutta la Francia. I suoi
antenati avevano servito per secoli la propria patria, fin dal tempo delle
Crociate: fra questi si potevano trovare un Maresciallo, nove generali e quattro
luogotenenti reali. Ventenne, a una brillante carriera militare garantita dal
proprio rango, preferì arruolarsi in cavalleria dove, dopo aver raggiunto il
grado di sergente, entrò alla Scuola di Cavalleria
Samour, come allievo
ufficiale. Ottimo cavallerrizzo, nel 1933 e nel 1935 conquistò due titoli
internazionali. All'inizio del secondo conflitto mondiale entrò, come
volontario, nel
Corps Francs, un'unità di tipo commando che si sarebbe
distinta per il valore nella lotta contro l'occupazione tedesca. Catturato nel
giugno del 1940, dopo aver opposto resistenza, con soli 60 uomini, a un intero
battaglione della Wehrmacht, peraltro supportato da unità corazzate, riuscì a
fuggire, il 31 marzo del 1941,
dall'Oflag IV-D, un campo di massima
sicurezza in Slesia.
![]() |
Una pattuglia
di soldati francesi in ricognizione
nella foresta bruciata dal
napalm |
Vi era stato confinato dopo altri tre
tentativi di evasione. Fra il 1944 e il 1945 fu a capo di uno squadrone
corazzato e nel 1946 venne assegnato in Indocina. Fra le motivazione della
scelta di incaricare de Castries delle operazioni nella neocostituita base
aeroterrestre, fu determinante l'esperienza del nobiluomo francese alla guida di
unità mobili. Si reputava infatti che le caratteristiche della valle avrebbero
consentito un modello di difesa, anche nel caso di una manovra avvolgente
nemica, incentrata su azioni diversive e suppportata dall'impiego di unità
corazzate. Ad affiancare de Castries nella difesa di Dien Bien Phu si trovò il
tenente colonnello Pierre Charles Langlais, nato in Bretagna nel 1902. Dopo aver
servito nelle truppe mehariste, il prestigioso corpo cammellato di stanza nel
Sahara, e aver preso parte alle principali campagne nella seconda guerra
mondiale, Langlais era giunto in Indocina nel 1945. Con l'avvicendamento al
comando fra Gille e de Castries, e l'arrivo di unità di fanteria in sostituzione
dei paracadutisti, stava per avere inizio la prima fase delle operazioni che
avrebbero coinvolto Dien Bien Phu. Il 30 novembre elementi dell'8° battaglione
d'assalto paracadutisti sotto il comando del capitano Pierre Turret, con il
supporto delle unità
T'ai da montagna del capitano Guilleminot, si
apprestava a penetrare venti chilometri di jungla per minacciare, con azioni di
disturbo, le linee di comunicazione dei
Viet-Minh, come si facevano
chiamere le truppe vietnamite comuniste. Con il medesimo scopo erano stati
attivati alcuni
commando coordinati dal maggiore Roger Trinquier e
dipendenti direttamente dall'
intelligence francese. La possibilità di
dirigere un raid direttamente contro Tuan Giao, a nord est di Dien Bien Phu,
principale punto di rifornimento dell'Esercito Popolare Vietnamita nella
regione, fallì miseramente dopo due interminabili giorni di marcia attraverso la
fitta vegetazione. Alle 9:45 del 5 dicembre del 1953 la compagnia di Turret
aveva appena trasmesso via radio un messaggio in cui si parlava di sospetta
attività nemica.
A quel punto i mortai
Viet Minh aprirono il fuoco
sulla fanteria francese che, solo con il provvido intervento della propria
artiglieria, fu in grado di sfuggire alla carneficina. Sul terreno restavano
quattordici morti e ventisei feriti. Il nemico aveva provveduto a cancellare le
tracce della propria presenza portando con sè, come di consueto, feriti e
cadaveri. La perquisizione di alcune salme che i comunisti non avevano fatto in
tempo a nascondere portò alla luce informazioni ben più preoccupanti.
L'imboscata non era stata tesa dalla guerriglia, ma dai regolari della 316°
Divisione dell'Esercito Popolare. La morsa vietnamita intorno a Dien Bien Phu
stava prendendo drammaticamente forma. Una sorte ben più drammatica sarebbe
toccata, nei giorni seguenti a coloro che, in seguito all'evacuazione di Lai
Chau, avrebbero dovuto raggiungere a piedi il campo di Dien Bien Phu. I notabili
del regime vietnamita, assieme ai parenti più stretti, alla popolazione civile e
gran parte delle truppe di stanza in quella che fino a pochi giorni prima era la
sede del governo filofrancese, furono evacuati, con successo e senza alcuna
perdita, dall'aviazione cinese. Altri dovettero aprirsi la strada nella
vegetazione circostante, giocando una partita a scacchi mortale con i
vietminh, i quali, disseminati per l'intero territorio, calarono sulle
colonne nemiche con mortale precisione. Le perdite fra i francesi furono
elevatissime e le numeroso missioni di soccorso, condotte con il supporto di una
squadriglia di
B-26, riuscirono a limitare solo in parte le ingenti
perdite. I morti e i dispersi si contarono a migliaia, forse più di duemila.
Concluse le operazioni per l'evacuazione di Lai Chau, a Dien Bien Phu
fervevano i preparativi per l'imminente scontro, ma, nell'illusione di riuscire
a fermare l'avanzata nemica con azioni di disturbo, le missioni di ricognizioni
continuavano a assorbire gran parte della forza lavoro della base.
![]() |
Terra
bruciata a Dien Bien Phu: un gruppo di
militari francesi in un
drammatico scenario |
Gli sforzi maggiori
erano diretti a riaprire la strada che conduceva a Sop Nao, nel Laos, a
cinquanta miglia di distanza. Le condizioni del territorio erano però tali da
far ritenere vano qualsiasi tentativo anche al più attento osservatore.
Senza la minaccia diretta del nemico, nella vicina Burma l'esercito USA
aveva infatti impiegato, nel corso della Seconda guerra mondiale, oltre diciotto
mesi per costruire 120 miglia di strada, disponendo di mezzi ben più
consistenti. L'operazione di ricognizione avrebbe assunto la duplice
denominazione di
Ardeche e
Regate. Un primo gruppo, composto
dal 5° Battaglione di Chaussers del Laos, comandato dal maggiore Vandrej e dal
5° Tabor marocchino, comandato dal maggiore Coquet, sarebbe dovuto partire dal
Laos, mentre un analogo gruppo, guidato dal tenente colonnello Langlais sarebbe
partito da Dien Bien Phu. Come gli operai francesi e italiani si incontrarono
all'interno del traforo del Monte Bianco, così i militari si sarebbero
incontrati all'interno della jungla, a metà strada da Sop Nao. L'evento venne
salutato con entusiasmo dalla stampa, che poteva comunicare al resto del mondo
la fine dell'isolamento di Dien Bien Phu. Il ritorno, sotto le costanti
incursioni dei
vietminh, non fu meno arduo e alla fine si ammise che
sarebbero occorsi mesi alla realizzazione di una strada praticabile. Mentre i
distaccamenti preposti all'operazione
Ardeche celebravano il giorno di
Natale nella fitta vegetazione indocinese, nella piana di Dien Bien Phu, dove la
vegetazione aveva lasciato spazio a un enorme accampamento di 15.000 persone,
venivano radunati i primi cingolati di quello che sarebbe diventato il nucleo
delle unità mobili della piazzaforte. Costituito da carri armati leggeri,
modelli
M-24, familiarmente soprannominati
bisonti dagli
uomini di de Castries, avrebbe ricoperto un ruolo fondamentale nei momenti più
difficili del lungo assedio. Dopo una serie di insuccessi e vittorie parziali,
l'11 marzo del 1954 Langlais guiderà il secondo gruppo aerotrasportato per
l'ultima volta in una operazione di ricognizione su larga scala. L'obiettivo era
però ben più vicino, la
collina 555, a soli due miglia di distanza,
dove i comunisti stavano iniziando a scavare i trinceramenti e si apprestavano a
scagliare l'attacco finale. Questo ebbe luogo solo due giorni dopo. In quel
momento lo schieramento francese era acquartierato in una serie di piazzaforti e
trinceramenti che, uno dopo l'altro, sarebbero stati condannati, a causa della
penuria degli uomini, dei mezzi e della precarietà delle stesse strutture di
difesa, penalizzate dall'endemica scarsità di materiale da costruzione, a cadere
inesorabilmente sotto il fuoco nemico. Ogni posizione aveva assunto il nome di
una donna.
I pettegoli, o forse i meglio informati, affermeranno in seguito
che corrispondevano a quelli delle numerose amanti di de Castries. A nord, lungo
la
Pavie Track, si trovava
Gabrielle, dotata di una batteria
di mortai pesanti in grado di coprire la zona di atterraggio per gli aerei, a
sua volta protetta dai bunker e dal filo spinato di
Anne-Marie.
Anne-Marie si trovava al centro dello schieramento. A est erano situate
Huguette,
Françoise e
Claudine, a ovest
Dominique e
Eliane. Quest'ultima era minacciata da
presso da due colline la cui occupazione, benchè di importanza strategica, era
stata resa impossibile dalla scarsità degli uomini a disposizione.
Dominique, pur trovandosi in una posizione privilegiata, in grado di
dominare, a causa della quota delle postazioni, l'intera valle, era dotata di
difese estremamente precarie, le uniche classificate come tali durante i
sopralluoghi ufficiali. A nord ovest, a quota 506 si trovava invece
Beatrice, lungo la
Route 41. A sud
Isabelle e
Wienne che controllavano la striscia di atterraggio ausiliaria.
Marcelle, dislocata lungo il fiume Nam Yum, a metà strada fra il nucleo
principale dell'accampamento e
Isabelle, era stata evacuata in seguito
alle piogge monsoniche, quell'anno particolarmente intense, che avevano
sensibilmente mutato l'aspetto dell'intera pianura. Con non pochi problemi per
le squadre del genio e il lancio dei rifornimenti.
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
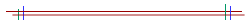 |
 |
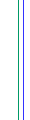 |
Gli uomini di
Gabrielle, francesi
e nordafricani,
combatterono
fino
all'ultimo |
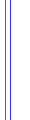 |
 |
 |
 |
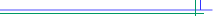 |
 |
La
pioggia non aveva però interrotto le linee di comunicazione dei
vietminh, i quali potevano contare sul contributo di decine di migliaia
di
coolies, gli infaticabili lavoratori asiatici che non si
risparmiavano, pur essendo stati nella maggior parte dei casi reclutati sotto la
minaccia delle mitragliatrici, per portare a termine il proprio compito. Dove i
camion
Molotova non arrivavano, ci riuscivano le biciclette e dove le
biciclette si dimostravano inutili potevano contare sugli animali da carico,
quando anche quest'ultimi non erano più in grado di proseguire il cammino allora
i
coolies sostenevano il carico con la forza delle proprie spalle.
Un'impresa non certo trascurabile considerando il terreno fangoso e le frequenti
incursioni dell'aviazione francese sotto il cui fuoco, nonostante non vi siano
cifre ufficiali, caddero probabilmente migliaia di vietnamiti.
L'intervento
aereo, com'era fallito in Corea, così si era dimostrato del tutto inutile per
fermare l'avanzata nemica e, nel marzo del 1954, il generale Giap poteva contare
su una forza di combattimento di quasi 50.000 uomini, pari al 60% dell'intero
schieramento comunista. I francesi abili al servizio erano meno di 15.000, circa
il 4% dell'intero esercito in Indocina, e ormai non più in condizione di
evacuare il campo. Erano però le truppe migliori di cui potesse disporre Parigi
nell'Estremo Oriente e la loro perdita non sarebbe potuta essere sostenibile.
Come previsto dall'
intelligence, il momento tanto atteso ebbe inizio la
sera del 13 marzo, alle 17.00. Una pioggia di bombe aveva iniziato a investire
in pieno
Beatrice, mentre
Gabrielle doveva assistere impotente
alla distruzione degli ultimi velivoli rimasti nella base. Il fuoco
dell'artiglieria nemica era eccezionalmente preciso: così come era stata precisa
la mimetizzazione dei cannoni la presenza dei quali era sfuggita, nei giorni
precedenti, ai ricognitori francesi. Dopo poco più di un'ora i reggimenti 141 e
219 della 312° divisione dell'Esercito Popolare uscirono dalle trincee per
scagliare il primo assalto. Gli uomini di
Gabrielle, francesi e
nordafricani, combatterono fino all'ultimo, spesso solo per salvare la propria
vita all'interno della mischia, ma le perdite risultarono pesanti da ambo le
parti. L'artiglieria nemica era oltretutto riuscita a portare a segno una serie
di tiri diretti verso il comando della postazione, colpendo mortalmente lo
stesso colonnello Gaucher, a capo della piazzaforte. La quale, pur proseguendo
nella propria eroica resistenza, si trovava ormai priva di un comando. Alle
20.30 erano state interrotte le comunicazioni radio e gli uomini erano guidati
dai sergenti maggiori e dai caporali non essendo sopravvissuto nemmeno un
ufficiale. Gli obici dell'artiglieria pesante del colonnello Piroth riuscirono a
contenere l'assalto per altre due ore, ma alle 2.00 della notte del 14 marzo il
sergente Kubiak e i superstiti del 3° battaglione, assieme ad alcuni legionari,
abbandonarono la postazione per rifugiarsi nella boscaglia, attendendo la luce
del giorno per raggiungere i commilitoni.
Il colpo di maglio successivo
venne sferrato il 15 marzo contro
Gabrielle. Alle 3.30 della notte il
bombardamento delle artiglierie
viet-minh, rinforzato da due nuove
batterie, iniziò, lento e inesorabile, a battere la piazzaforte. Le ondate della
fanteria comunista vennero in un primo momento ostacolate dai proiettili delle
mitragliere francesi, ma anche l'Esercito Popolare era ben equipaggiato e tre
colpi ben assestati di
bazooka furono sufficienti a indebolire la
difesa. Fra le vittime giaceva il capitano Narbey, comandante della 1a
compagnia; accanto a lui, gravemente ferito, il tenente Roux. Il gruppo rimase
nelle mani di due caporali algerini, Noueredine e Abderrahman, mentre i mortai
di
Gabrielle soccombevano definitivamente sotto il fuoco
dell'artiglieria nemica. La piazzaforte era però dotata di una seconda linea di
difesa e i francesi erano determinati a non cedere il passo alle incursioni
avversarie. Com'era successo per Beatrice anche le comunicazioni radio di
Gabrielle cessarono improvvisamente. Feriti anche il maggiore Kah e il
maggiore de Mecquenem, i più alti ufficiali in grado, il comando passò al
capitano Gendre poco prima delle 5.00. I rinforzi da lui prontamente richiesti e
almeno in un primo tempo garantiti da Langlais, tardavano però ad arrivare.
![]() |
Un cimitero
di caduti dell'esercito popolare
vietnamita (foto di Marylin Knapp)
|
Alle 5.30 ebbe luogo il contrattacco,
guidato dal maggiore Seguin-Pazzis con l'ausilio dei cingolati del capitano
Hervoet. All'azione presero parte, con indomito vigore, anche gli uomini della
Legione Straniera, ma i
vietminh penetrarono fulmineamente le falle
lasciate aperte. Dopo aver riguadagnato per breve tempo la sommità della
postazione, i francesi dovettero accettare la sconfitta e ripiegare. Alle 9:00
del mattino lo scontro poteva considerarsi concluso. Alcuni soldati di
nazionalità francese e parigina combatterono fino all'ultima cartuccia, ma il
loro accanimento fu vano. Con la caduta di
Gabrielle, lo schieramento
di de Castries si trovava in una situazione estremamente critica, esposto più
che mai al tiro nemico, mentre anche i rifornimenti, che dovevano essere
necessariamente aerotrasportati, scarseggiavano. L'aviazione francese si trovò
per la prima volta in quei giorni nel bersaglio dell'antiarea
vietminh.
Quest'ultima, allestita grazie agli aiuti cinesi, era oltretutto particolarmente
precisa, al punto da essere considerata migliore di quella tedesca nel corso
della 2a Guerra mondiale.
Nei giorni seguenti la morsa dei
vietminh
sembrò allentarsi: probabilmente dovevano rinsaldare i ranghi dopo le perdite
pagate per la conquista di
Beatrice e
Gabrielle. Il comando
francese ne approfittò per lanciare una sortita contro le batterie nemiche e,
alle 19.00 del 27 marzo, il maggiore Bigeard fu incaricato di effettuare una
sortita verso il fronte occidentale dell'accerchiamento. I paracadutisti del
6° BPC piombarono sulle linee comuniste riuscendo a cogliere
l'avversario di sorpresa e l'assalto, conclusosi con successo, seppur a caro
prezzo, contribuì a risollevare il morale della guarnigione. Nel frattempo la
stampa del mondo libero concentrava la propria attenzione sul destino di quelli
che ormai erano noti come gli
eroi di Dien Bien Phu mentre ad Hanoi si
stavano individuando alcune soluzioni per uscire dall'
impasse. Fra il
30 e il 31 marzo
Dominique fu investita dall'assalto della 312°
Divisione dell'Esercito Popolare. Presi dal panico in seguito allo scontro che
aveva visto scomparire nel nulla gli algerini e i partigiani
T´ai
dislocati nel punto più basso della postazione, i fucilieri nordafricani
iniziarono ad abbandonare il proprio posto e, presi dal panico, a fuggire in
tutte le direzioni. I disertori, nei 55 giorni dell'assedio, raggiunsero la
cifra di 4.000 fra francesi, marocchini, algerini e vietnamiti. Rifugiatisi su
un'isola del fiume che attraversava la valle, furono soprannominati i
Ratti
dello Nam Yum. Nella notte, come topi affamati, si dirigevano verso
l'accampamento per fare incetta di viveri. L'avanzata comunista si fermò poco
dopo, quando, non potendo più contare sul supporto della propria artiglieria, i
vietminh dovettero attestarsi su nuove posizioni. Anche
Eliane
era stata investita dall'attacco, ma i paracadutisti francesi e i legionari
tedeschi seppero resistere con valore e condurre il contrattacco con successo; i
marocchini del capitano Nicolas si distinsero per la tenacia con cui mantennero
il proprio posto. Buona parte delle difese di
Eliane e
Dominique erano però ormai in mano avversarie e, mentre ad Hanoi si
reclutavano i volontari per le ultime disperate missioni di rinforzo, a sud
dello schieramente anche
Isabelle rischiava l'isolamento.
Huguette, che comprendeva l'area della pista di atterraggio, fu
l'obiettivo successivo dei
vietminh. Le truppe corazzate, i legionari e
i paracadutisti, questa volta intervenuti per tempo, seppero però, almeno per la
prima fase dello scontro, avvenuto fra il 3 e il 6 aprile, respingere l'assalto.
In quegli stessi giorni ripresero i combattimenti intorno a
Eliane.
I francesi, riconosciutane l'importanza strategica per la sopravvivenza
dell'intero accampamento, avevano deciso di riconquistarla a ogni costo e il 10
aprile, dopo una settimana di aspri scontri, anche le posizioni più avanzate
della roccaforte erano nuovamente nelle mani dei legionari. Fra il 12 e il 18
aprile
Huguette doveva però sostenere nuovamente l'attacco
dell'Esercito Popolare, questa volta più compatto, e i francesi, persa ormai
metà della pista di atterraggio, dovettero ulteriormente ripiegare sul sistema
difensivo denominato
Opera, poco distante dal centro di comando. Con il
rafforzamento delle posizioni comuniste anche i rifornimenti paracadutati
quotidianamente si facevano più difficili. Le perdite, dovute all'imprecisione
dei lanci, raggiungevano il 50%. Fra il 19 e il 21 aprile ebbe luogo la seconda
e ultima fase della battaglia per
Huguette. I legionari e i marocchini
si ritirarono con ordine, mentre l'aviazione colpiva ripetutamente le nuove
posizioni dei comunisti. Ma quando il contrattacco francese fallì a questi
ultimi non rimase che accettare la sorte. Intorno alla fine di aprile caddero
anche le precarie comunicazioni con
Isabelle, ormai completamente
isolata. La sorte di Dien Bien Phu sembrava ormai segnata, l'unica speranza era
riposta nell'intervento americano. Gli USA, con le loro portaerei dislocate nel
Pacifico, avrebbero potuto far intervenire l'aviazione contro lo schieramento
vietminh, ormai ben compatto e facilmente localizzabile. Probabilmente
l'azione sarebbe stata sufficiente per salvare quel che rimaneva della
guarnigione francese, ma negli alti comandi americani prevalsero i timori delle
conseguenze di una simile decisione. Non solo l'azione avrebbe infatti
giustificato l'intervento cinese, ma avrebbe altresì posto gli Stati Uniti in
cattiva luce di fronte all'opinione pubblica mondiale proprio mentre a Ginevra
le Nazioni Unite stavano discutendo sulle sorti del Viet Nam. Le ragioni
diplomatiche volevano che Dien Bien Phu tenesse fino all'ultimo, almeno fino a
dopo la conclusione della conferenza. Navarre aveva autorizzato de Castries, in
caso di estrema emergenza, a tentare una sortita, che in effetti avrebbe avuto
le caratteristiche di una rotta, ma non ad alzare bandiera bianca. La sortita
non fu possibile e, ormai stremati, gli uomini di Dien Bien Phu cessarono di
combattere il 7 maggio. Alle 17.30 i
vietminh, come concordato con una
delegazione dei pochi ufficiali superstiti, occuparono le ultime postazioni
rimaste in campo francese. De Castries e oltre 10.000 uomini caddero
prigionieri. Combattere fino all'ultima cartuccia sarebbe risultato troppo
costoso in termini di vite umane. Fra il 6 il 7 maggio alcuni uomini morirono,
senza alcun segno apparente, per il solo sforzo fisico che avevano richiesto 55
giorni di combattimenti. Al ministro degli esteri francese Bidault non rimase
che chiedere la pace. Una pace che si concludeva con la sconfitta di Parigi e la
fine del sogno di riconquista dell'Impero. Fra i prigionieri solo pochi
riuscirono a fuggire, alcuni tornarono nella madre patria anni più tardi, altri
morirono di stenti nei campi di prigionia asiatici, altri ancora, come gli
algerini, sottoposti al lavaggio del cervello, si troveranno a combattere, pochi
mesi dopo, contro lo stesso vessillo sotto il quale si erano ricoperti di
gloria.